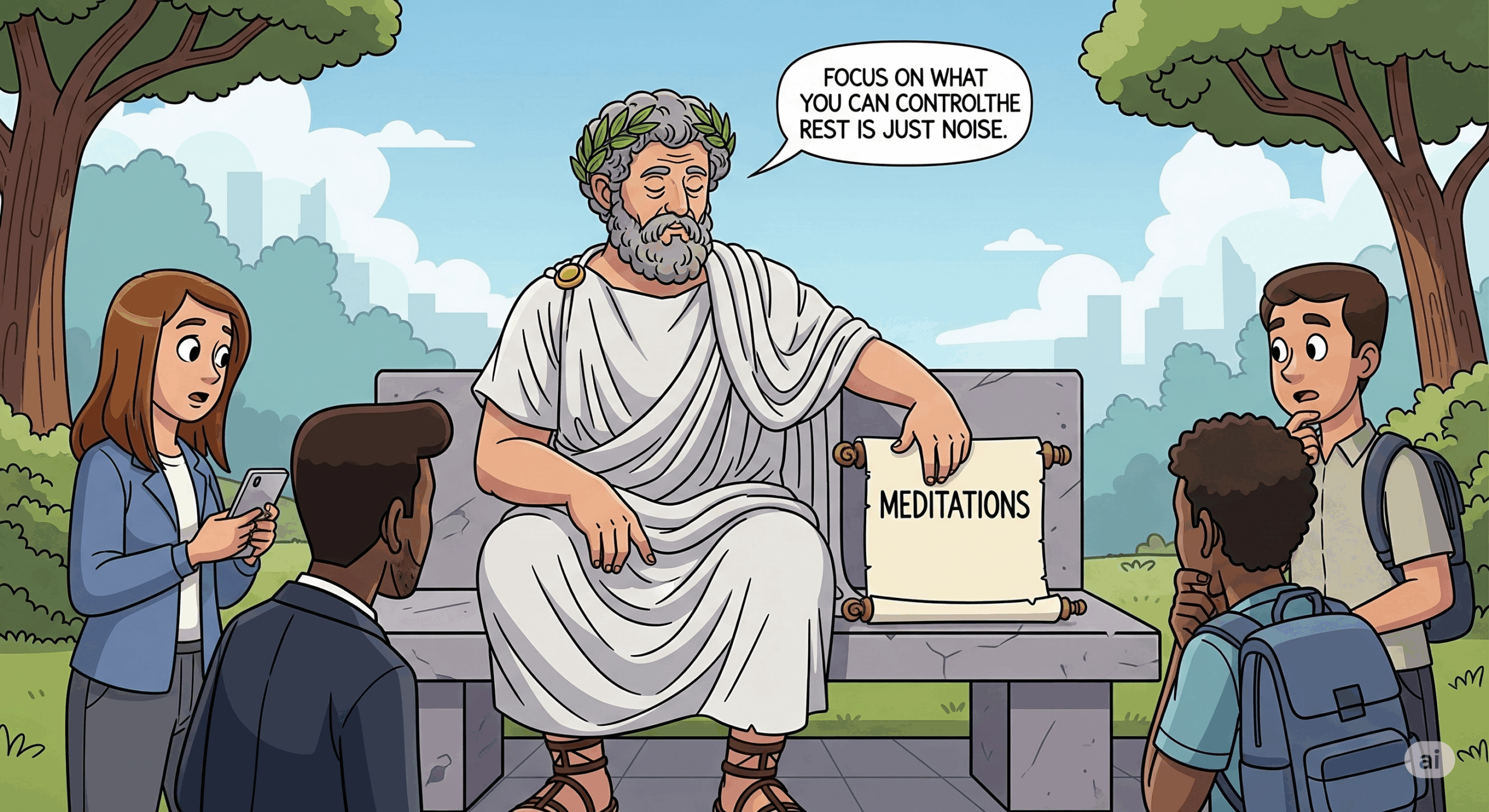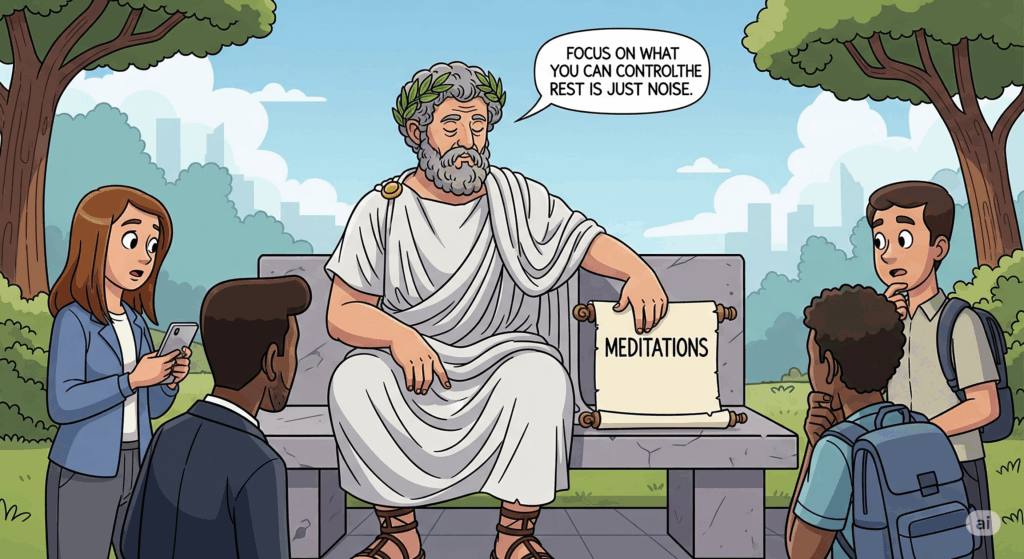
Lo stoicismo è la corrente filosofica più longeva di sempre, è giunta sino a noi come una sorta di raccolta di regola d’oro per vivere in salute e serenità. Molte delle sue affermazioni sono state oggi verificate dalla ricerca psicologia ed esistono 3 pilastri che, secondo lo storico ed esperto di filosofia antica Pierre Hadot, fa parte di ogni insegnamento stoico che si rispetti. Hadot la chiama la tripartizione di Marco Aurelio ma ci spiega come fosse già presente in altri pensatori del passato… vedrai che assomiglia praticamente a tutto ciò di cui senti parlare di anni nel campo della crescita personale:
Stoicismo
Come sa chi mi segue da tempo io adoro tutta la filosofia e ho da tempo una sbandata per lo Stoicismo. Chiunque abbia seguito i nostri percorsi sa che ne abbiamo uno fatto con Riccardo Dal Ferro dedicato proprio a questo tema e, se per caso ami l’argomento sai che con Rick ho fatto ore e ore di chiacchierate di questo genere sul suo canale. Insomma non è la prima volta che qui su Psinel parliamo di Stoicismo ma è una delle prime volte in cui ti presento uno schema generale per interpretarlo. Non è farina del mio sacco ma lo trovi dentro il magistrale lavoro dello storico Pierre Hadot, in quel piccolo capolavoro che si intitola: Esercizi spirituali e filosofia antica.
Forse non è la prima volta che me lo senti nominare, lo uso spesso come argomento per dimostrare alcune cose rilevanti: la prima è che forme di meditazione di consapevolezza erano già presenti in occidente (così come le più note di oriente), e che, le filosofie antiche erano più simili a vere e proprie palestre di crescita personale. Hadot insiste molto su questo punto, i filosofi antichi non si limitavano a fare speculazioni ma cercavano di vivere in base a ciò che professavano, erano veri e propri precetti di vita che nascevano dall’uso intenzionale della ragione (e non affidandosi a tradizioni o miti).
Secondo Hadot questi 3 temi (o topoi) sono da ricercarsi in tutta la storia dello stoicismo ed in particolare in Epitteto, lo schiavo filosofo. Questa differenza tra Marco Aurelio, imperatore ed Epitteto schiavo ha affascinato l’immaginario di moltissime persone, compreso il mio. La distanza storica tra i due non è così grande come si possa immaginare: Epitteto è vissuto tra 50 – 125 d.c. mentre Marco Aurelio dal 121 al 180 d.c. cosa interessante è che il primo è nato schiavo ma poi si è liberato, ed è da quel momento che ha iniziato la sua opera filosofica. Ma perché allora ho scelto Marco Aurelio come rappresentante di questi 3 passaggi?
Perché in realtà di Epitteto abbiamo pochissimo, solo ciò che ci è stato riportato dai suoi allievi, lui non ha mai scritto nulla (almeno così pare), al contrario Marco Aurelio è stato un autore prolifico ed i suoi scritti sono giunti sino a noi. Cosa abbastanza semplice da immaginare, è molto probabile che le idee di un qualche pensatore indipendente che non sta scrivendo nulla sul web, che non abbia pubblicato libri, per quanto illuminino il cammino di molti difficilmente resterà “nella storia”. Al contrario l’autobiografia di un qualsiasi presidente del Consiglio verrà conservata e probabilmente studiata anche tra 1000 anni (chissà se è una questione più socio-economica o più socio-politica ma è abbastanza plausibile che non sia stata la validità delle idee a preservarle nella storia).
Secondo molti non tutti i filosofi stoici si sono concentrati in egual misura su questi tre temi, ad esempio Epitteto spingeva molto sul concetto di ciò che possiamo controllare. Il quale ad un primo sguardo sembra solo un semplice ragionamento razionale: ci sono cose che posso controllare ed altre che non posso controllare. Il problema, come succede sempre non è tanto di capire la distinzione razionale tra i due (la quale è abbastanza elementare) ma è accorgerci di quando, inconsapevolmente, stiamo cercando di controllare ciò che non si può controllare.
La saggezza antica
Molte volte su Psinel ti ho parlato della ricerca scientifica e di quanto sia importante guardare avanti (metaforicamente parlando) ma anche voltarsi indietro non è affatto stupido. Infatti le migliori intuizioni non nascono mai nel vuoto, anche per chi come me è appassionato di aspetti legati all’evidenza. La saggezza antica esiste? Si, in un qualche modo possiamo ritrovare in una enorme quantità di materiale ogni dramma attuale e passato, ogni idea e gesto che ci possa venire in mente (o quasi). Ma come è possibile una cosa del genere?
Una risposta plausibile è che siamo simili ai nostri antenati di migliaia di anni fa. E che questi, attraverso la propria vita, attraverso la propria esperienza avessero intuito aspetti della nostra esistenza anche molto profondi. Nel campo delle scienze dure questo è abbastanza evidente, giusto per fare qualche esempio: gli antichi greci avevano scoperto il pi greco, calcolato la circonferenza della terra (sapevano che non era piatta), usavano il vapore per animare dei giochi per bambini (senza saperlo avevano inventato il motore a vapore millenni prima della sua ri-scoperta e adozione) ecc.
Come vedi non sono nozioni chiare come le immaginiamo oggi che abbiamo codici per spiegarle e catalogarle. Erano intuizioni e informazioni che restavano ancorate a quel tipo di cultura, la quale vedeva in alcuni contesti la morale e l’etica come figlie della religione. Potremmo dire “nulla mi è sconosciuto in quanto uomo”, sempre per citare qualcosa dal passato che ci dice, che infondo, se sei un essere umano puoi ipotizzare tutto ciò che passa per la testa di qualsiasi altro essere umano… presente, passato e come sembra, anche futuro.
Ovviamente tali suggerimenti e come vedremo tali dogmi, erano presentati in forme diverse in base alla cultura di riferimento. Ah forse era bene dirlo prima, ma in questo momento non mi riferisco solo allo stoicismo ma a tutta la cultura in generale. La quale ha da sempre cercato di trasmettere, oltre a consigli potremmo dire pratici anche condotte di vita morali, quindi come devi pensare e agire per raggiungere “la felicità” (ad esempio per gli aristotelici), la virtù, la saggezza, ecc. Insomma è come se da un qualche punto di vista ci occupassimo di crescita personale da sempre!
Tuttavia sappiamo bene che le cose non sono così semplici, nonostante si abbiano probabilmente archivi infiniti di consigli saggi non è detto che questi poi vengano messi in pratica. Nelle prossime righe proverò ad avanzare alcune ipotesi personali, mi perdonino anticipatamente i veri filosofi se semplifico o se dico cose per loro banali. In caso vi aspetto nella nostra live del giovedì mattina per discuterne insieme…
L’integrazione contemporanea
Questa faccenda fa parte di tutti e 3 i temi, i quali aiutano davvero quando riusciamo a metterli in pratica nella realtà, il che implica l’accorgerci di comportarci in modo non armonico con essi. Questa faccenda che prende molti nomi (meta-cognizione, consapevolezza ecc.) non era così chiara un tempo, si dava per scontato che la gente, una volta assimilata una certa informazione poi si ricordasse di praticarla. Ma come sappiamo questa cosa non è affatto vera, ne abbiamo diverse prove nella storia, se fossimo riusciti sempre a gestire la nostra interiorità in questo modo probabilmente oggi saremmo tutti dei santi.
Ed invece le cose per molti sono peggiorate, le continue distrazioni digitali, la società della prestazione che ci invita ad essere tutti prestanti, il tipo di modello economico imperante e molto altro stanno distruggendo tutto… compresa la nostra capacità di accorgerci dei nostri movimenti interni. Quindi anche di renderci conto se una cosa è controllabile o meno, di non riuscire ad accettare realtà alternative alle nostre aspettative, di essere sempre meno tolleranti nei confronti delle emozioni difficili. Insomma viviamo in un’epoca facile che come dice un detto, crea persone deboli, le quali generano tempi difficili… ecc.
Se mi segui sai che non amo troppo questa narrazione, infatti come ti dicevo non è che gli antichi fossero più bravi di noi nel difficile compito di portare avanti i propri buoni propositi. E non era solo una questione di cultura, certo poverini non avevano Psinel ma erano di certo abbastanza intelligenti e consapevoli da accorgersi di cosa accadeva. Tuttavia l’idea che fossero forse meno flessibili mentalmente a me suona particolarmente bene, e come sai da questo nostro episodio, quando parlo di flessibilità mi rivolgo ad una serie di abilità molto importanti e specifiche.
E’ come se oggi, di fronte a moltissimi modelli differenti di comportamento ci si incagli in una sorta di paradosso della scelta, anche per chi come te desidera migliorare se stesso ci si trova spesso in una sorta di giungla della scelta. Ed è qui che entra un tema ancora più generale: cosa determina la scelta? Le risposte sono tantissime, dall’ambiente alla genetica passando per le nostre abitudini. Ma ciò che più realmente aiuta non è sapere cosa fare ma è accorgersi che è il momento di farlo! La nostra cara consapevolezza o più tecnicamente la meta-cognizione. Senza questo aspetto, che è stato citato in un qualche modo tra le righe di ogni stoico, nulla aiuta realmente.
Tornando alla visione di Hadot, cioè di una filosofia come stile di vita, sembra logico immaginare che un discepolo cercasse costantemente di stare attento a comportarsi nel modo più adeguato. Tuttavia tali conoscenze erano in mano a pochissime persone rispetto alla popolazione, le condizioni di vita stesse di quel periodo impedivano loro di accedere a determinate conoscenze (fame, carestie, analfabetismo imperante ecc.). Credo in fondo che l’adesione quasi fideistica, quasi da setta, fosse la chiave per la meta-cognizione. Se vivi secondo certi principi diventano poi una seconda pelle, se invece devi ricordarli di tanto in tanto le cose sono più difficili.
La Flessibilità mentale
Bhe allora la chiave per una buona crescita personale è semplice: creiamo sette! Sto scherzando… no, dobbiamo fare l’esatto opposto, liberare le persone non renderle schiave. Ma con la libertà arriva anche la possibilità che il “tenere a mente ciò che è giusto fare” sia anche più difficile e più complesso. In questo rientra la nostra consapevolezza, oggi sempre più importante per riuscire a vivere non sempre in virtù ma per lo meno in flessibilità mentale. Cioè avere la capacità di accorgersi delle cose che ci passano per la testa e di notare dove siamo incagliati… non ci serve aderire ad una setta!
L’adesione metaforica ad una setta, il credere fino in fondo che le cose stiano in un certo modo aiuta ma allo stesso tempo imprigiona! In questo momento sto esaltando la consapevolezza e di certo è qualcosa che può aiutarci in ogni momento della nostra vita. Tuttavia non è detto che sia sempre importante essere presenti e vigili, ci sono momenti di tranquillità, di gioco, di coinvolgimento, di spensieratezza, per i quali essere troppo presenti non va così bene. La chiave è sempre la flessibilità, non il cercare di aderire ad un credo in modo ferreo e neanche essere troppo inconsapevoli… anzi!
Perché ti dico queste cose? Perché se oggi corri a comprarti un libro di Marco Aurelio e lo leggi, oltre a ritrovare un sapore aulico nella prosa trovi pure unacertezza assoluta in ciò che si consiglia. Questo, secondo me, faceva parte di quel tipo di atteggiamento necessario affinché qualcuno potesse trarvi un vantaggio (è ancora il tema di Hadot sulla filosofia come approccio alla vita e non solo come esercizio mentale) ma oggi le cose sono molto diverse. Nessuno si aspetta leggendo un libro di trovare la verità assoluta, perché di “verità del genere” ne abbiamo fin troppe a disposizione (ancora il paradosso della scelta).
Quindi come fare? Dobbiamo aumentare la nostra meta-cognizione di questi aspetti, il che implica realmente cercare di capire se qualcosa è o meno sotto il nostro controllo quando questo qualcosa ci attanaglia. Comprendere cosa possiamo accogliere e cosa no nel momento in cui siamo vittime di lotte interiori che cercando di fuggire, risolvere e comprendere cose indecidibili (sono intelligente oppure no? Come mi vedono davvero gli altri? ecc.). Il termine usato dagli stoici, “disciplina” è probabilmente il più azzecato di tutti ma allo stesso tempo spaventa.
Come ricorderai il nostro cervello è pigro, quando legge termini che richiamano la fatica tende ad accoglierli poco. Quando leggi o ascolti termini come: impegno, sforzo, disciplina e dedizione… tendi a chiudere le porte della mente. E non lo fai solo tu, lo facciamo tutti in determinate circostanze. Certo è possibile che leggendo “disciplina o dedizione” ti sia venuto in mente un esempio virtuoso come Michael Jordan allora forse si è accesa una lampadina dentro di te. Ecco io vorrei che questi termini avessero queste nuove associazioni nella tua/nostra mente!
Quindi se ti è saltato in mente qualcosa di virtuoso probabilmente sei già sulla buona strada… in caso fammelo sapere tra i nostri punti di contatto (instagram e le live del giovedì mattina), ci farò sicuramente un altro contenuto. Mi sembra una buona missione da intraprendere per i prossimi mesi: cambiare il frame relazionale di questi termini!
A presto
Genna