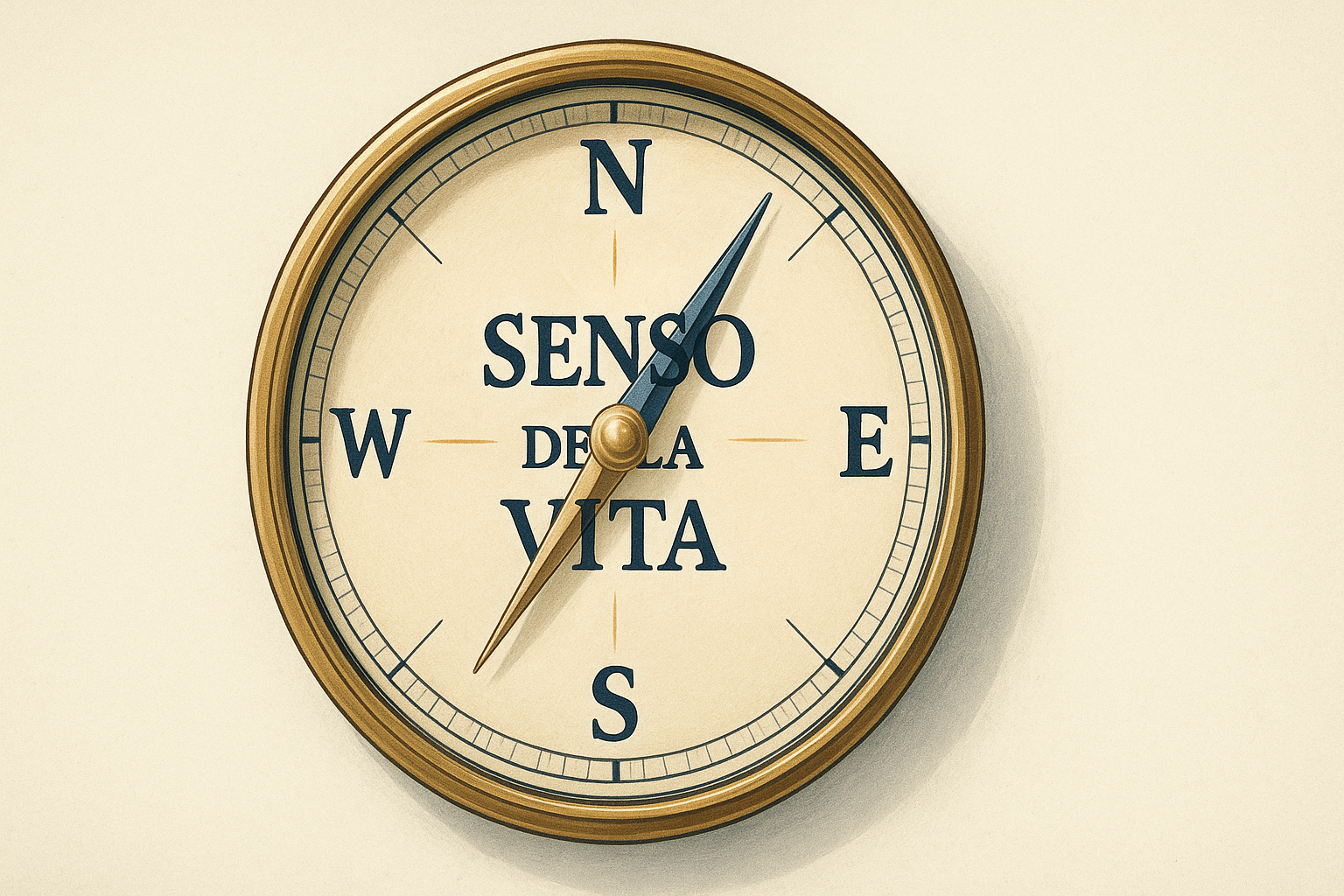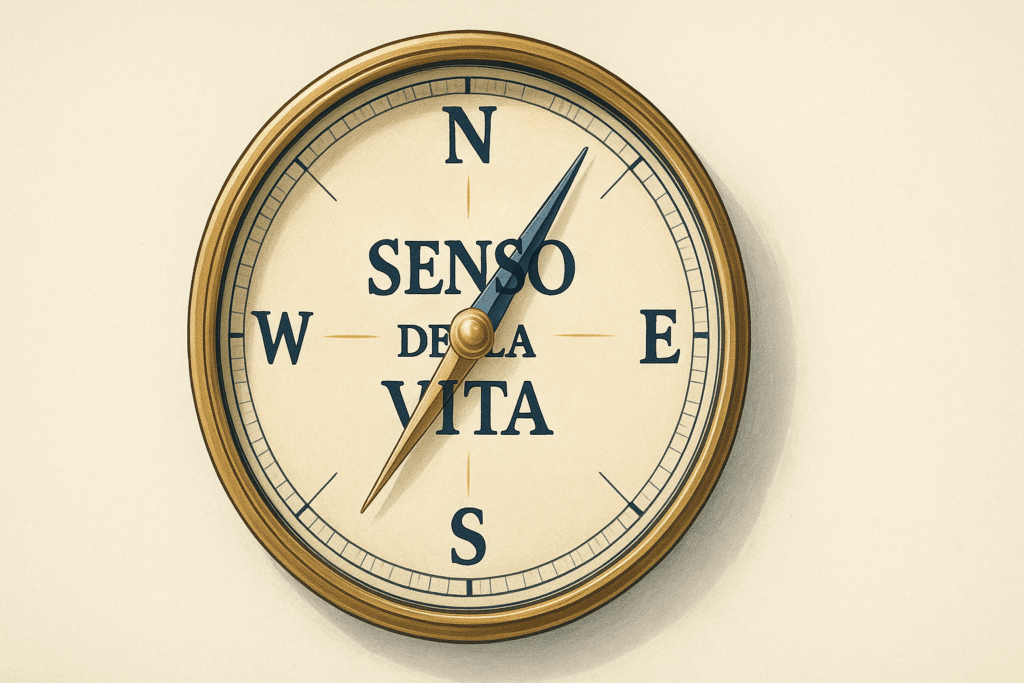
Quante volte ti sei chiesto che senso abbia la vita? Forse mai, anche se è poco probabile dato che ognuno di noi si è posto domande su questo tema. Filosofi e pensatori di tutti i tempi ne hanno parlato, opere letterarie e canzoni pop citano di continuo questo argomento. La psicologia ha cercato in molti modi di dare alcune risposte, oggi voglio mostrarti quelle più semplici ma allo stesso tempo pratiche, per aiutarci a dare un senso… al senso della vita!
Animali in cerca di senso: la spiegazione facile
Per molti pensatori e colleghi vicini e lontani, noi siamo animali in cerca di senso. Un’affermazione molto potente che in realtà nasconde una profondità vertiginosa, oggi vorrei fare un po’ il sempliciotto e mostrarti che, tale nostra inclinazione potrebbe non essere così esclusiva. Partiamo dai nostri cugini animali, anche loro hanno alcuni meccanismi di base che potremmo attribuire ad una ricerca di senso, da alcune prospettive. Ora probabilmente stai pensando che io sia impazzito, il “senso” per noi è sinonimo di significato e, significato è sinonimo di concetti astratti tratti dal linguaggio… e gli animali, non hanno il linguaggio.
Sì gli animali non parlano ma hanno un loro linguaggio, per quanto diverso e meno flessibile del nostro e, per molti evoluzionisti è proprio da questa sorta di proto-linguaggio che è nato il nostro. Se vediamo il tutto in modo basilare potremmo vedere la creazione del significato come una tendenza degli organismi ad un adattamento costante all’ambiente. E come fanno gli organismi ad adattarsi agli ambienti? Regolano la loro energia in base a ciò che gli accade. E questa regolazione energetica viene massimizzata da una abilità incredibile: la capacità di prevedere ciò che accade nel futuro.
Come fa un magazzino di un negozio ad essere efficiente? Lo diventa quando riesce ad avere le giuste scorte di prodotti ma non troppe, la giusta quantità. E come fanno tutti gli anni i negozianti a sapere quanta merce acquistare? Lo fanno sulla previsione di ciò che ha funzionato nel periodo precedente. Più sono bravi a fare questa previsione e meno soldi devono spendere. Ecco l’organismo fa qualcosa del genere con la gestione dell’energia, cerca di rendere il mondo prevedibile. In un qualche modo lo fa tutto il regno vivente, cerca di allocare in modo saggio le proprie energie basandosi sulle “esperienze” del passato.
Per farlo utilizziamo la capacità di riconoscere ricorrenze e nessi nel mondo. Più siamo bravi a fare questa operazione e più siamo in grado di massimizzare le nostre previsioni. Ogni previsione fallita richiede un adattamento dell’organismo (delle mappe di rappresentazione del mondo) il quale a sua volta richiede energia… e agli organismi non piace troppo spendere energie. La natura ha fatto sì che tale meccanismo fosse massimizzato dalle varie nicchie ecologiche, così ha costruito degli istinti capaci di attivarsi in relazione all’ambiente circostante. Il top del risparmio energetico!
Noi esseri umani però non abbiamo delle vere e proprie nicchie ecologiche, non abbiamo un abbinamento perfetto tra ambiente ed il nostro organismo. Per questo motivo siamo evoluti attraverso la tecnica che ci ha consentito di modificare l’ambiente al fine di poter, a nostra volta, prevedere in modo sicuro il mondo intorno a noi. Secondo Michael Tomasello ci siamo arrivati accrescendo di volta in volta la nostra capacità di agire sul mondo, man mano che questo diventava sempre meno ospitale per noi, ne abbiamo parlato in questo episodio. Quindi il senso della vita è solo il senso che diamo al mondo per sopravvivere? Si e no…
La versione difficile
Noi non possiamo fare a meno di dare senso alle cose che viviamo. Non conta il grado di cultura, lo stato socio-economico, noi diamo senso alle cose che ci stanno attorno anche quando il senso non esiste! Lo facciamo proprio per poter dare ordine e prevedibilità alla nostra esperienza. Quando dico “senso” intendo che non possiamo fare a meno di creare legami di causa-effetto tra gli eventi, anche quando questi legami non ci sono. E sembra essere un fenomeno che ci ha consentito di sopravvivere in modo piuttosto efficace fino ad ora.
Ai nostri antenati non importava identificare il principio chimico che rendeva velenosa una pianta, gli bastava sapere che era pericolosa e attribuirgli un carattere demoniaco, cattivo o qualsiasi altra narrazione abbastanza convincente. Se poi un giorno qualcuno scopriva che, usare una parte di quella pianta sarebbe potuto anche essere positivo, magari come farmaco, allora si doveva aggiornare il legame causa-effetto, il senso attribuito a quella pianta. Questo meccanismo nasce dalle previsioni che facciamo sul mondo, dalla nostra esperienza con queste previsioni e dalla loro revisione costante.
Oggi sappiamo che il nostro modo di agire è per così dire “statistico”, noi formuliamo costantemente probabilità su ciò che sta per accaderci, per aggiornare quel nostro magazzino. Ma questo continuo aggiornare è faticoso, spesso ci basta sapere che quella pianta fa del male, per evitare di continuare a cogitare sulla faccenda. Non solo, per poterne parlare con gli altri membri della nostra specie dobbiamo per così dire dare “un nome a quella situazione” e dobbiamo spiegarne la causalità da noi osservata. Per sopravvivere è bene dare subito un senso a ciò che ci troviamo di fronte, che sia grossolano o preciso poco conta.
Se vedi qualcosa che sembra un serpente su un sentiero di montagna reagirai come se fosse un serpente, anche se si tratta di un ramo. Non perché sei un fifone ma perché per il tuo cervello poco conta essere preciso con quel tipo di previsione, i serpenti sono talmente pericolosi che va bene anche sbagliare se è il caso. Ma quando invece dobbiamo soppesare questioni più rilevanti, con gradi di astrazione più elevati, cose che riguardano sensi più ampi, come quello della vita… ecco che la questione cambia parecchio e non possiamo più affidarci al nostro sistema che si “accontenta” della prima impressione.
Quindi da un lato siamo capacissimi dare senso alle cose semplici che ci capitano, soprattutto se hanno a che fare con la possibilità di disperdere energie (e/o di morire) e dall’altro lato facciamo fatica a dare senso alla nostra vita. Perché? E qui serve un simposio di filosofia (e non è uno scherzo) ma se restiamo ancorati al funzionamento del nostro organismo e della nostra mente possiamo provare a dare alcune piccole spiegazioni e forse anche alcune indicazioni.
Simboli
La capacità dell’essere umano di creare astrazioni e di condividerle, quella che spesso viene chiamata “abilità simbolica”, è stata la chiave per la nostra sopravvivenza. Come spiegano antropologi e storici, la grande abilità degli esseri umani è stata quella di poter collaborare in grandi quantità di membri della stessa specie. Nel regno animale esiste la cooperazione ma è spesso molto limitata, sia nei numeri che negli intenti, anche se abbiamo esempi mirabili tra gli insetti e i volatili di cooperazione. Ma quelli sembrano tutti dettati appunto da legami di tipo biologico… a noi questo legame non basta!
Per poter mettere tante persone tutte insieme, fare in modo che collaborino tra loro è necessario non solo che condividano aspetti biologici ma che possano scambiarsi simbologie a cui aderire: una bandiera, un popolo, il nome di una tribù, ecc. Tutto questo noi lo abbiamo fatto attraverso la parola e più precisamente attraverso le narrazioni. Tutto questo naturalmente nasce da un substrato biologico (sempre come ci dice Tomasello), immaginando due nostri avi, sconosciuti entrambi intenti nella ricerca di cibo. Magari entrambi dietro a piccole prede, di colpo si rendono conto che c’è una preda più grande e che, l’unico modo di cacciarla è collaborare.
Per collaborare meglio abbiamo imparato a dare un senso comune a specifici suoni e segnali, da qui è nata la parola e poi il linguaggio. Questi simboli condivisi e co-creati di cui oggi siamo realmente zeppi (stati, nazioni, mercati, monete, filosofie, ecc.) ci servono sempre per sopravvivere al meglio, cioè risparmiando energie. Questo succede anche in piccolo, diamo per scontato che la gente si comporti in modo relativamente prevedibile intorno a noi: se andiamo in stazione e mentre aspettiamo il treno un tizio, fruga nelle tasche in modo nervoso, non pensiamo che stia per estrarre un’arma… più facile che cerchi il biglietto, no?
Un popolo ha questa caratteristica, norme e consuetudini ben delineate che aiutano le persone a sapere cosa è giusto e cosa non è giusto fare. Si esatto, la legge, e queste regole servono proprio per limitare la nostra sensazione di minaccia naturale che proveremmo incontrando uno sconosciuto per strada in un luogo che non conosciamo per nulla. Oggi sembra un discorso assurdo questo ma ti assicuro che fino ad una manciata di secoli fa la gente ti ammazzava per pochissimo ed esistono ancora luoghi del genere. Ora tu mi dirai: “ma tutto questo cosa diavolo c’entra con il senso della vita?”… ci arriviamo.
Non appena qualcosa acquisisce senso diventa meno minacciosa, diventa più facile da comprendere e da esplorare. Ed è proprio ciò che accade a livello biologico, ti ricordi i Sistemi motivazionali interpersonali? Ecco passiamo dal sistema di minaccia e rango a quello esplorativo e di cooperazione. Ora ti sembrerà strano ma succede anche dentro di te: “come mai Tommaso non mi ha salutato oggi al bar?”… “mah sai ultimamente non va d’accordo con sua moglie e forse era solo triste”. Questa spiegazione che diamo a noi stessi ferma il continuo pensare e ripensare (la macchina probabilistica) e ci rasserena… anche se quella ipotesi potrebbe non essere affatto vera! (magari è davvero arrabbiato con noi).
La mente stocastica
Qualche anno fa ho chiamato così un nostro episodio, per sottolineare il pervasivo prevedere della mente di cui, solitamente, non ci rendiamo affatto conto. Non mi riferisco solo ad una situazione negativa come il rimuginare o il ruminare ma faccio riferimento a come naturalmente funzionano i nostri pensieri, i quali, hanno sempre questa caratteristica di previsione del mondo. Tali previsioni non sono completamente casuali ma dipendono dal tuo passato, dal contesto e dalle tue aspettative sul contesto. Questo continuo pensare in modo probabilistico ha un solo fine: farci agire meglio.
Prevediamo, agiamo e abbiamo un feedback dalla realtà che aggiusta la previsione e la prossima azione. Ora in realtà le cose non sono così lineari, l’azione è già un atto di predizione. Lo so sembra strano ma prova questo gioco con un tuo amico: mettigli davanti 3 bicchieri di differenti dimensioni di diametro, fai in modo che le differenze siano molto marcate. Poi chiedigli di scegliere uno solo di quei 3 bicchieri e digli di afferrarlo lentamente. Prova a fermarlo pochi istanti prima che lo afferri e fagli notare come ha posizionato la mano.
Il tuo amico scoprirà che inconsapevolmente aveva già predisposto la mano a prendere quel tipo di bicchiere. E’ come se la mano sapesse esattamente quanto allargarsi e stringere in base al bicchiere che ha di fronte (tecnicamente la chiamiamo affordance). Questa roba che sembra scontata ci mostra che in realtà facciamo sempre previsioni e che queste sono incorporate nelle nostre azioni. Per questo molti neuroscienziati affermano che il sistema motorio è anche un sistema percettivo-cognitivo, ma non voglio confonderti eccessivamente, mi serve solo per mostrarti il fondamento della previsione mentale (e fisica) sembra in azione. E per togliere il velo dall’idea che prima ci siano i pensieri e poi le azioni quando in realtà è tutto mescolato.
Tra le previsioni che tendiamo a fare c’è proprio la domanda esistenziale: ma quale senso ha o dovrebbe avere la mia vita? E’ una domanda che ti poni praticamente da sempre e a cui, da sempre, in base a quel momento, dai una tipo di risposta. Non sempre la stessa, non sempre uguale ma spesso molto simile. Tuttavia le domande esistenziali (come abbiamo già visto) sono anche state descritte (dal prof. Giorgio Nardone) come domande indecidibili: cioè domande a cui non esiste una risposta precisa e forse non esisterà mai. Questo significa che è stupido porsele? Assolutamente no, ma è stupido pensare che siano la chiave per stare bene.
Detta così sembra uno schiaffo a tutti i miei colleghi che vogliono trovare il senso della vita, agli approcci esistenzialisti (ed in parte lo è). La stupidità qui sta nel credere di poter dare una risposta univoca, assoluta, sicura, così come la possiamo dare a molte altre cose intorno e dentro di noi. Queste domande è come se mandassero fuori giri la nostra macchina pensante che non è così brava ad interrompere quel continuo prevedere, anzi direi che lo fa di continuo. Quindi certo che possiamo porcele, certo che possono essere utili ma solo se lo facciamo “a tavolino” e tenendo a mente che l’ambiguità non si risolverà.
Alla ricerca di certezze
Una mente davvero efficace è una mente in grado di riuscire a tollerare l’ambiguità delle domande esistenziali della vita. Non perché le ignora ma perchè sa che sono complesse, perché sa che le aspettative costruite in questo modo sono mappe per muoversi nel mondo e non certezze, nel momento in cui si fa la proverbiale confusione tra mappa e territorio si rischia di essere risucchiati da vortici di pensieri inconcludenti. Per i quali spesso cerchiamo di pensare con ancora maggiore intensità nel tentativo di venirne a capo… e allora si che può trasformarsi in rimuginio e ruminazione.
Oggi, grazie alla tecnologia abbiamo anche la sensazione di poter risolvere tutto. Se un tempo appena avevamo un dubbio correvamo a fare ricerche sul web, oggi non ne abbiamo quasi bisogno, chiediamo direttamente alla nostra intelligenza artificiale di toglierci le castagne dal fuoco. Il rischio è non riuscire più a gestire una semplice ambiguità come il non ricordarsi la capitale di uno Stato a mandarci in tilt, figurati una domanda sul senso della vita. Soprattutto se questa sorge in un periodo difficile, uno di quelli nei quali ci sembra proprio di averlo perso quel senso della vita.
Ripeto: questo non significa che tu non possa porti quelle domande ma che è bene capire che, non hai una risposta immediata, che quella risposta non arriverà a salvarti e che… rullo di tamburi, se non agisci in una certa direzione non lo capirai mai! Ecco il punto, tutte quelle meravigliose domande che ci poniamo servono per agire meglio nella nostra vita, limitarci a pensarle rischia di chiuderci in vortici di semi-senso che mandano fuori giri la mente. Il che può bloccarci in una sorta di paralisi dell’analisi del senso della vita… su noi stessi.
Questo è ancora un altro tema, il fatto che la domanda sul senso della vita non è (quasi) mai spersonalizzata, non è una domanda puramente filosofica (a meno che tu non stia scrivendo un trattato) ma è una domanda su noi stessi, su come IO dovrei vivere, che poi può anche essere vista, spesso mascherata da domanda per il genere umano. Infatti potremmo dire che tra le varie domande esistenziali di questo genere c’è anche questa: chi sono io? Altra domanda che manda fuori giri il nostro sistema di narrazione auto-biografica no stop che abbiamo tra le orecchie.
Tutte queste domande filosofiche possono essere affrontate, davvero in modo filosofico, quindi: studiando il pensiero di chi ci ha preceduti su questo tema, riconoscendone la enorme vastità, diventando flessibili sui vari punti di vista ecc. Oppure da un punto di vista psicologico, allora di certo la filosofia può aiutarci ma la ricerca ci invita a porci domande sul senso, su quelli che vengono comunemente chiamati valori, in forma di esercizio e di comportamento. Non è solo pensare al senso della vita ma è cercare di vivere in base a ciò che pensiamo essere per noi il senso della vita, unico modo per rivelarlo nel tempo.
Esplorare i nostri “sensi della vita”
Per evitare che queste domande fondamentali diventino trappole la cosa migliore da fare è analizzarle attraverso dei comportamenti e non solo attraverso i pensieri (perché questi sono previsioni). Il primo comportamento che avvicina molto pensiero e azione è la meravigliosa scrittura, lo so può apparire banale ma non lo è per niente. Scrivere non è pensare! O meglio è il tentativo di rendere esplicito qualcosa che pensiamo ma a ben vedere, si tratta di un’azione fisica che compiamo, lo stesso vale per la parola (fino ad un certo punto) ed è per questo che molti approcci di terapia funzionano.
Parlare non è pensare. E’ anche in questo caso cercare di fare ordine tra le molte previsioni. Per questo motivo, chiunque desideri perseguire nel cammino valoriale del senso della vita dovrebbe munirsi di carta e penna, in caso si può fare anche al computer o nel caso abbiate difficoltà dettando a voce ad un registratore (come vi dicevo, anche parlare non è solo pensare ma è cercare di mettere ordine ai pensieri).
Quindi ribadisco l’unico modo per vivere il senso della vita non è cercarlo come se fosse una cosa ma intraprenderlo come se fosse un viaggio, per questo dobbiamo affidarci alle azioni e non solo ai pensieri, i quali sono forieri di molte interpretazioni differenti. E’ come se il pensiero dicesse: fino a quando non ho capito, controllato ed interpretato tutto, tu non sarai mai sereno perché io continuerò a cercare. Ma è una piccola illusione che può essere spezzata proprio dall’azione e dal comportamento.
Ho una bella metafora in merito sulla ricerca del senso della vita, riguarda un’auto che viaggia di notte. Immaginiamo un’auto che parte di notte in una strada buia, i suoi abbaglianti possono illuminare ma solo fino ad un certo punto, per qualche metro davanti a noi. E’ banale ma se ci pensi non puoi illuminare tutta la strada puoi solo farlo metro dopo metro, ecco questa è una meravigliosa metafora di come dovremmo affrontare il futuro. Perché è questo che in realtà ci stiamo chiedendo quando cerchiamo di dare un senso alla nostra vita.
Spesso, nel mio studio, il valore più grande e più semplice da perseguire sono gli altri. Cioè i nostri cari, i nostri figli, i nostri partner, e quando a volte la gente si trova confusa può essere utile usare anche loro come fari. Ma sempre ricordando che nessuno di questi può illuminare tutta la strada.
A presto
Genna